|

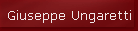
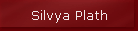
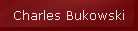
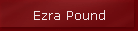
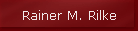
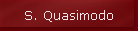



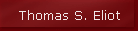


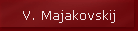

| |
Acque percorse! Boschi
di begli alberi!
Odore di mirtilli e
betulle!
Vento di molte voci
che va ondulando un alito
mite come se fossero,
quei recipienti del ferro e del latte
che rotolano là dalla
fattoria bianca, aperti!
Odoro e suono e
immagine e senso si confondono.
L'esule siede nella
valletta dei salici e torna
a riprendere il suo
arduo mestiere: sperare.
Bertolt Brecht
Nato a Augusburg [Baviera] nel 1898 (morto a Berlin nel 1956), figlio
dell'amministratore delegato di un'impresa industriale,. Il suo nome completo
era Eugen Berthold Firedrich Brecht. Cominciò a scrivere pubblicamente durante
la prima guerra. Cronista teatrale, divenne amico del comico K. Valentin.
Trasferitosi a Monaco (1920) e poi a Berlin (1924), lavorò per il teatro
collaborando con i registi M. Reinhardt e Erwin Piscator, con i musicisti Kurt
Weill, Hans Eisler e P. Hindemith, con gli scrittori A. Bronnen e L.
Feuchtwanger, con il disegnatore G. Grosz. Nel 1926 sposò l'attrice Helene
Weigel. Si avvicinò al marxismo influenzato da F. Sternberg, W. Benjamin, e
soprattutto da K. Korsch. Dopo il 1930 agì sempre più in stretto contatto con il
partito comunista tedesco.
Il giorno dopo l'incendio del Reichstag lasciò la Germania. Dopo brevi soste in
Svizzera e francia si stabilì a Svendborg (isola di Langeland, Danimarca)
insieme alla moglie e alla collaboratrici Margarethe Steffin e Ruth Berlau.
Nel 1935 compì viaggi a Mosca New-York e Paris dove pronunciò un polemico
intervento al congresso degli scrittori antifascisti. Nel 1939-1940 fu in
Svezia. Quando i nazisti invasero la Danimarca, riparò in Finlandia e nel maggio
1941, poco prima che le truppe naziste entrassero anche in quel paese, scampò a
Mosca da dove, via Vladivostok, raggiunse fortunosamente gli Stati Uniti dove
rimase per sei anni, quasi isolato. Visse progettando film per Hollywood.
Collaborò con il poeta W.H. Auden e con il regista Fritz Lang. Nel 1947, regista
J. Losey, con C. Laughton come attore protagonista, andò in scena a Hollywood
con scarso successo Vita di Galilei. Inquisito dal Comitato per le attività
antiamericane, tornò in europa nel 1948. Raggiunse Berlin est, dove organizzò la
celebre compagnia Berliner Ensemble (1949), prima al Deutsches Theater e poi al
Theater am Schiffbauerdamm, insieme alla moglie l’attrice Helene Weigel. Fino
all'ultimo lottò contro la burocrazia del regime.
LA
PRODUZIONE POETICA
La produzione poetica di Brecht è vasta ma assai
disordinata: in parte non raccolta in volume, in parte intrecciata alla
struttura dei drammi teatrali, entro i quali trovano posto non di rado canzoni
in versi. D'altra parte la poesia doveva essere, nelle intenzioni dell'autore,
un utensile, uno strumento di azione e di insegnamento, un momento dunque tutt'altro
che assoluto e supremo dell'attività intellettuale.
Dalla poesia brechtiana è esclusa la figura dell'io quale centro emotivo del
discorso: l'io, quando esiste, è esso stesso parte in causa e oggetto di
riflessione e di analisi. Manca inoltre ogni effetto di scoperta del mondo
nell'atto della scrittura: i versi si misurano piuttosto con la dura esistenza
della realtà, prendendovi posizione con nettezza. In questo modo vengono meno
due dei caratteri fondamentali della struttura lirica della tradizione moderna.
Quanto al linguaggio, l'interesse brechtiano non è mai per la suggestione
analogica, per la raffinatezza retorico-formale, per lo scontro tra significante
e significato; possono esservi giochi di parole, ma la lingua non è mai oggetto
di interesse in se stessa: al contrario, la lingua è asservita a un fine pratico
di conoscenza, di dimostrazione e di persuasione. La parzialità è il punto
d'onore della lirica brechtiana, ma, essendo escluso ogni privilegio soggettivo,
si tratta di una parzialità fondata su valori non personali ma politici e
ideologici. Da questo punto di vista ben si mostra la connessione organica tra
posizioni di poetica e posizioni ideologiche, che per Brecht significano
adesione alla prospettiva marxista della lotta di classe: la poesia è al
servizio di questa parzialità di classe.
I temi brechtiani prendono spesso spunto dalla cronaca, soprattutto la più
comune e bassa, con un gusto anche del grottesco e del macabro e della
deformazione di marca espressionistica. Gli episodi di cronaca assumono un
rilievo allegorico grazie al caricamento di senso che il poeta s'incarica di
compiere, generalmente in modo del tutto esplicito e dichiarato. A volte a
essere soggetto dei testi sono direttamente le grandi questioni
storico-politiche che riguardano il presente, come la vittoria del nazismo e la
scelta della guerra; in questi casi la posizione dell'autore, identificata con
quella di classe del proletariato, è fatta risaltare o per mezzo del contrasto
ironico o attraverso l'impiego di tecniche epigrammatiche di grande efficacia,
senza escludere tuttavia la possibilità dell'apostrofe e dell'invettiva.
Brecht dunque ha operato una vera e propria inversione di tendenza rispetto agli
orientamenti otto-novecenteschi. Alle suggestioni dell'ineffabile e alla
dilatazione semantica della parola ha sostituito la concretezza del linguaggio
preciso e, come è stato detto, «oltraggiosamente prosastico», all'ansia
dell'ignoto il rapporto con concrete situazioni storico-sociali, alle
disperazioni solipsistiche il dovere per il poeta di assumere nel suo lavoro
precise responsabilità sociali, all'evasione dalla realtà i concreti
interrogativi sulla realtà. Moltissime delle sue canzoni, songs, ballate e
liriche sono state musicate da Kurt Weil.

|
