|

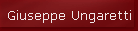
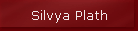
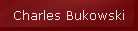
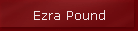
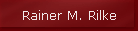
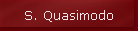



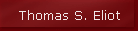


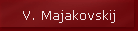

| |
Dino Campana
Una canzonetta
volgaruccia era morta
E mi aveva lasciato il
cuore nel dolore
E me ne andavo errando
senz'amore
Lasciando il cuore mio
di porta in porta:
Con Lei che non è mai
nata eppure è morta
E mi ha lasciato il
cuore senza amore:
Eppure il cuore porta
nel dolore:
Lasciando il cuore mio
di porta in porta.
Nella sua
rubrica "Esame di giornalismo", divertente rassegna di stramberie e "bufale"
giornalistiche che allieta ogni giovedì i lettori di Sette, qualche settimana fa
Giulio Nascimbeni annotava testualmente: "Tempi duri (sui giornali) per i poeti.
Il Resto del Carlino annuncia che, in occasione del premio Guidarello, si terrà
un incontro sulla 'Ravenna dei poeti' dedicato a Guido Campana. Ma Campana,
l'autore dei Canti orfici, si chiamava Dino. L'esattezza nel citare è sempre più
rara: lo ripeteremo fino alla sazietà".
Parole sante, alle quali ci permettiamo di aggiungere, in coro con Eduardo De
Filippo, che gli esami non finiscono mai. E anche Nascimbeni non esce del tutto
indenne dal nostro - umilissimo, per carità: il titolo esatto del capolavoro di
Campana non è, infatti, Canti orfici ma Canti Orfici, come l'autore stesso si
era tante volte incaponito nel segnalare al suo primo editore, il tipografo
Ravagli di Marradi, cui aveva commissionato la stampa (a sue spese) di mille
copie dell'opera, pretendendo persino nel contratto che il titolo venisse
stampato con entrambe le lettere iniziali in maiuscolo.
Avrete notato la minuscola (tipograficamente parlando) ma decisiva differenza.
La quale ci introduce ottimamente alla storia di Dino Campana, quant'altre mai
fatta di tragici equivoci umani e letterari.
Questi nostri vagabondaggi sulle tracce della poesia "maledetta" - quella che
vuole andare oltre il sensibile, l'intellegibile, il visibile - ci hanno
condotto in luoghi e tempi molto diversi tra loro. Partiti dalla metà
dell'Ottocento e dalla Francia, dove per la prima volta Baudelaire fece piazza
pulita delle norme che tradizionalmente presiedevano al fare poesia,
conservandone solo il meraviglioso involucro - la tecnica, la perfezione
formale, l'arte di concentrare una sola vibrante intuizione in versi purissimi -
per potervi mettere dentro tutta l'angoscia dell'uomo moderno, quell'angoscia
che nessuno aveva ancora avuto il coraggio di mettere a nudo in modo tanto
spietato (e pagando con la vita la sua arte), siamo poi approdati ai suoi più
grandi epigoni: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé e tutti i loro compagni di salotti
letterari, banchetti e orge. Poeti diversissimi tra loro, eppure tutti
"maledetti": dalla poesia, più che dalla vita.
Siamo poi sbarcati in America e abbiamo incontrato Poe, che tutti i francesi
riconoscevano loro maestro; e sempre in America, dopo un salto di un secolo, ci
siamo trovati di fronte l'enfant terrible del rock, Jim Morrison, poeta e Re
Lucertola dalla voce potente e incantatrice.
Ora torniamo nuovamente indietro nel tempo, e vicino vicino nello spazio.
Marradi, grosso paese in provincia di Firenze, 1885. Il 20 agosto nasce Dino
Campana da Giovanni, maestro elementare, e Francesca Luti, detta Fanny.
La maledizione è sbarcata sul suolo italiano. Non quella imparaticcia degli
scapigliati, che un paio di decenni prima avevano portato un po' della bohéme
parigina a Milano, urlando ai quattro venti le loro giovanili intemperanze e
ribellioni per poi venire tutti, tranne qualche raro caso, tranquillamente
riassorbiti nei salotti buoni della borghesia intellettuale.
Dino Campana fu e rimane un esiliato, un reietto, una presenza quanto meno
scomoda e difficilmente catalogabile nei cassetti pre-etichettati dei nostrani
contenitori di storia della letteratura. Perché? Vedremo, vedrete. Campana è
poeta assai denso, va aggirato con circospezione; Campana fu un uomo complicato,
non lo si poteva avvicinare troppo in fretta. E poi esiste la leggenda di Dino
Campana il matto - il mat, a Marradi - che come tutte le leggende contiene
sentieri di verità che nascostamente si innestano su autostrade di invenzioni:
una leggenda in cui svettano gli episodi clamorosi, i colpi di scena, le fughe e
le prigioni, mentre la poesia e la vita restano dimessamente in secondo piano.
I primi, ma proprio i primissimi, anni di Campana sono piuttosto normali:
frequenta le scuole elementari a Marradi, poi viene iscritto al collegio dei
Salesiani di Faenza, dove studia al ginnasio. Nel 1900 è iscritto alla prima
classe del liceo classico di Faenza, e fa il pendolare tra casa e scuola.
Quell'anno, secondo la testimonianza del padre, si manifestano i primi
preoccupanti segni di disturbi nel comportamento del ragazzo. Ha frequenti
scoppi d'ira ed è molto violento, specie con la madre: una donna molto
silenziosa, spesso irritata, che mostra a sua volta, nella tendenza ad
allontanarsi periodicamente da casa, una buona dose di stranezza. A scuola lo
prendono in giro per le sue stramberie. Inevitabilmente, alla fine dell'anno
viene bocciato.
La carriera scolastica di Dino Campana procede ugualmente, alla meno peggio, e
in effetti il poeta arriva alla sospirata (dal padre) licenza liceale nel 1903.
Dopo di che, con una scelta quanto mai distante dalle sue aspirazioni e dai suoi
interessi, si iscrive alla facoltà di Chimica pura dell'Università di Bologna.
Nel frattempo hanno avuto inizio i vagabondaggi e le fughe: la prima volta
succede proprio durante l'ultimo anno di liceo. Partito a piedi per chissà dove,
viene arrestato e imprigionato a Parma dopo vari incidenti e risse. Dino ha
diciotto anni, capelli e barba biondo rossi, occhi azzurri. Scriverà più tardi
nei Canti Orfici, probabilmente parlando di se stesso: "Faust era giovane e
bello, aveva i capelli ricciuti".
I primi anni di università sono un vero disastro: non riesce a sostenere neppure
un esame e frequenta prevalentemente le lezioni di Lettere. Il padre decide
allora di mandarlo a Firenze presso uno zio magistrato, poi lo richiama a casa,
e la tensione in famiglia si fa sempre più vistosa. Nel 1906, dopo una nuova
fuga a Genova - che diventerà col tempo uno dei luoghi mitici di Campana - lo fa
visitare da un illustre specialista affinché questi ne autorizzi l'internamento
in manicomio al compimento del ventunesimo anno, cioè di lì a qualche mese. Dino
tenta una fuga ma viene riacchiappato in Francia e rispedito a Marradi e poi a
Imola, dove si aprono per lui, per la prima volta, le porte del manicomio.
Stabilita la sua infermità mentale dopo un periodo di osservazione durato un
mese, i medici decretano per Dino la perdita dei diritti civili e impongono la
nomina di un tutore nella persona del padre; il quale, infine, accetta di farlo
tornare a casa sotto la sua custodia. Comunque, Dino Campana è ormai
ufficialmente matto, e d'ora in poi i suoi compaesani cercheranno con ogni mezzo
di liberarsi della sua fastidiosa presenza. Di buon grado, dunque, la questura
gli rilascia, l'anno dopo, un passaporto speciale per Buenos Ayres.
Che fosse un poeta, a quell'epoca, non lo immaginava nessuno. Lui scriveva,
forse già da qualche anno, versi, pensieri e prose su un quaderno che verrà
ritrovato e pubblicato da un suo biografo molti anni dopo, rivelando come alcune
idee portanti e centrali della poetica campaniana fossero presenti fin
dall'inizio nei suoi scritti, venendo poi costantemente rielaborate in vista
della composizione del libro unico, i Canti Orfici appunto. Ma la storia degli
inediti campaniani è lunga e complicata, e non manca di offrire significative
particolarità: come ad esempio il fatto che questo stesso quaderno saltò fuori
per caso da una cassa di libri e vecchie cose che i familiari di Campana
tenevano in soffitta senza che balenasse loro l'idea di mostrarla a qualche
studioso di letteratura. E sì che nel 1942, anno del ritrovamento, l'opera di
Campana - defunto da tempo - aveva già attirato l'attenzione di editori e
critici. Come spiegare tanta incuria da parte di coloro che, a regola, più
dovevano avere a cuore l'eredità di Dino? Forse che le ombre gettate dai matti
sono più lunghe di quelle degli altri, e più nere, e si teme che possano
oscurare tutto ciò che lambiscono?
Nel 1909 Campana ancora aspetta che vengano sbrigate le pratiche per l'imbarco
verso il "nuovo mondo", meta agognata per liberarsi da quello vecchio che lo
incatena e del quale proprio lui, il matto, vede con lucidità le brutture, le
miserie, le ipocrisie.
I viaggi di Dino Campana sono in realtà un viaggio solo, sempre lo stesso: una
fuga verso cieli sconfinati e limpidi sotto i quali l'uomo possa sentirsi libero
e liberamente inserito in una Natura forte, potente, primitiva. Per questo una
delle sue mete d'elezione è Genova, città aperta sul mare nei cui porti vivono
uomini dalle braccia robuste e donne dagli enormi seni che accendono i sensi;
città moderna e antica, che unisce il fascino dell'avventura all'eterna
delusione del ritorno. Città che sintetizza il ciclo senza fine della vita e
della morte: quelli autentici, non quelli edulcorati della borghesia.
Mentre aspetta Campana si cimenta nella pittura, attività che gli è assai
congeniale e di cui si trovano non poche tracce nei suoi versi e nei suoi
scritti. Un appunto trovato su un altro di quegli inediti le cui vicende
starebbero egregiamente in una spy-story recita "ad ogni poesia fare un quadro".
Una riga, poche parole: che bastano, però, a far intendere in che modo Campana
si ponesse nei riguardi di entrambe. Montale aveva notato come Campana cercasse
di "giungere ad una completa dissoluzione coloristico-musicale del discorso
poetico"; un altro critico, Guglielmino, leggendo Piazza Sarzano si domandava
"come non pensare alle metafisiche 'piazze d'Italia' di De Chirico?".
Sempre mentre aspetta viene nuovamente ricoverato in manicomio, questa volta a
Firenze, e finisce anche in ospedale con fortissimi attacchi di febbre. Infine,
in autunno, si imbarca per l'Argentina. E scrive: "Io vidi dal ponte della nave
/ i colli di Spagna / svanire, nel verde / dentro il crepuscolo d'oro la bruna
terra celando...". È Viaggio a Montevideo, capolavoro in versi che fa tremare al
ricordo di ogni partenza.
L'avventura nel nuovo mondo dura poco: in gennaio Campana è mozzo su una nave
diretta ad Anversa, poi finisce in un manicomio belga dove rimane qualche mese
mentre le autorità locali e quelle italiane se lo palleggiano. Infine, con viva
delusione dei suoi concittadini, torna a casa. In settembre compie, a piedi, un
pellegrinaggio da Marradi al santuario della Verna, luogo delle stigmate di
Francesco d'Assisi. Il diario di quel viaggio diventerà più tardi il terzo
blocco dei Canti Orfici, un poema in prosa che esemplarmente riassume la poetica
campaniana. Il viaggio, innanzi tutto; quel trovarsi solo al confronto con una
terra inizialmente carica di storia e poi, man mano che si sale, sempre più nuda
coi suoi colori vergini nell'aria rarefatta. E sulla sommità, d'improvviso
spazzata dalle nebbie, ritrovare lo stupefacente nitore di colori e contorni,
ritrovare l'uomo finalmente restituito a se stesso.
Di ritorno dalla mistica esperienza della Verna, Dino riprende a girovagare tra
Firenze, Genova e Bologna. Intanto, nel 1912, pubblica per la prima volta alcuni
testi su un giornale studentesco; l'anno dopo decide di mettere in bella copia
le "novelle poetiche e poesie" che sta scrivendo da un decennio. Vuole trovare
un editore. Troverà, dopo cinque anni, un manicomio. L'ultimo.
Gli ultimi anni che Campana passa nel mondo dei sani sono quelli del suo
incontro, presto diventato scontro, con gli intellettuali e la letteratura
ufficiale. Della quale scriverà - ovviamente negli inediti - Vo alla latrina e
vomito (verità). / Letteratura nazionale / Industria del cadavere. / Si Salvi
Chi Può.
Nel 1913, a Genova, gli capita tra le mani un numero di Lacerba, rivista
fiorentina diretta dai futuristi Soffici e Papini. Ne rimane vivamente
impressionato, tanto da cercare un contatto più diretto con loro. I programmi
esposti nella rivista gli parevano quanto di più congeniale ci fosse alle sue
medesime aspirazioni: spazzare via l'arte del passato, fatta di vuoti
sentimentalismi e ossequi a schemi formali ormai vuoti (Uccidete il chiaro di
luna! era una delle parole d'ordine del futurismo); creare un'arte nuova, a
misura di un mondo dominato dalle scosse elettriche e dalla rapidità e quindi
libera da regole grammaticali e di bello stile. Tutto ciò piace molto a Campana,
che infatti scrive a Papini: "La vostra speranza sia: fondare l'alta coltura
italiana. Fondarla sul violento groviglio delle forze nelle città elettriche
delle selvagge anime del popolo, del vero popolo, non di una massa di lecchini,
finocchi, camerieri, cantastorie, saltimbanchi, giornalisti e filosofi come
siete a Firenze". Spinto dall'entusiasmo lascia Genova per Firenze, dove intende
incontrare i fondatori della nuova arte. E in effetti li incontra, ne riceve
generiche parole di apprezzamento unite al sottinteso fastidio di chi vuole
lasciar intendere di avere ben altro da fare. Ugualmente consegna a Papini e
Soffici il suo manoscritto, il suo tesoro. Loro lo sfogliano, lo spostano, lo
trasportano, e infine lo perdono.
Ebbene sì, lo smarriscono in un trasloco. Salterà poi fuori, nel 1971, nella
soffitta di casa Soffici. Ironia della sorte, si intitolava Il più lungo giorno
e conteneva, in forma meno elaborata, il nucleo essenziale dei Canti Orfici.
Per Campana è una tragedia dalla quale non si riprenderà che a tratti e per
breve tempo. Sono poi fiorite numerose leggende tragicomiche sul poeta pazzo che
minacciava di morte i due responsabili del tradimento, sfidandoli a duello e
indirizzando loro lettere minatorie. Ma mentre la "premiata ditta Papini &
Soffici" commetteva un errore la cui portata è tuttora incalcolabile, Campana si
ritrovava solo, a Marradi, a cercare di ricostruire con tenacia ossessiva la sua
opera.
Da lì in poi i rapporti di Campana con la cultura ufficiale saranno sempre
peggiori. Non ne accettava i compromessi e le viltà, il parlo bene di te sulla
mia rivista così tu farai altrettanto, i programmi rivoluzionari enunciati a
gran voce stando comodamente seduti nelle poltrone dei caffè più in voga.
Avrebbe potuto benissimo dire, con Rimbaud : "Non parlatemi più di artisti. Li
ho conosciuti bene, io, quei merli!". Invece scrisse: "Ci fu un tempo prima di
prendere coscienza della civiltà italiana contemporanea, che io potevo
scherzare. Ora questa civiltà mi ha messo addosso una serietà terribile. Perciò
io sono anche tragico e morale".
Dunque a Marradi, tra un viaggio e l'altro, si intestardisce nel cercare di
rimettere insieme i pezzi del suo libro, e alla fine ci riesce e firma un
contratto per la stampa di mille copie dei Canti Orfici. A sue spese. Prezzo di
ogni copia, due lire e cinquanta. Poi torna a Firenze e si mette nei caffè a
venderlo di persona, e pare che strappasse le pagine che secondo lui gli
acquirenti non avrebbero potuto capire. Dice la leggenda che a Marinetti, vate
del futurismo, abbia consegnato solo la copertina.
A parte alcuni testi sporadicamente usciti su alcune riviste, i Canti Orfici
sono l'unica opera di cui Campana abbia autorizzato la pubblicazione. Vero è che
forse gli è mancato il tempo per elaborare i numerosi appunti degli inediti,
tanto da esserne soddisfatto; ma resta comunque il fatto che questo è il "libro
unico" cui il poeta intendeva affidare la sua futura memorabilità.
L'importanza che Campana annetteva a quest'opera è già tutta nel titolo: Canti,
come quelli della più alta tradizione poetica italiana; Orfici, aggettivo cui la
maiuscola assegna pari dignità di significato, nel senso di esoterici, mistici,
cifrati. E difatti si aprono con La notte, poema in prosa orfico per eccellenza,
nel quale si rivela un procedimento tipico del poeta: come Caronte, egli
traghetta i lettori dalla sponda del reale, del dato concreto, a quella
visionaria dell'inconscio, dei fantasmi della mente. Così la notte di Campana
diventa "la notte dell'uomo di ogni tempo perso in mezzo alle allucinanti
apparizioni del sesso e della paura"; il tutto scandito dal costante trapasso da
prosa a poesia, e dalle ripetizioni che conferiscono al poema un andamento
circolare, come di spirale che si avvita su se stessa. La notte regna sovrana -
come suggestione di attese, tremori, baluginii di luce di miti lontani - in
tutti i Canti; e sullo sfondo di questa buia notte dell'inconscio si stagliano
figure misteriose ed emblematiche, spesso in vesti femminili: come la Chimera,
che dà il titolo a una delle più difficili (quanto a comprensione) liriche di
tutto il Novecento. Figura di donna, la Chimera, che racchiude nelle sue
misteriose sembianze di Gioconda leonardesca tutto il segreto della poesia, la
sacra poesia che può aprire le porte a un'arte istintiva e primordiale, sciolta
"da ogni legame intellettuale e storico - sono parole di Sergio Solmi - per
tuffarsi nella emozione vergine, per cogliere il flusso informe della realtà".
Gli scritti di Campana sono, dunque, notturni e orfici. Proprio per questo non
esiste in essi una trama, un ragionamento, una costruzione logica aprioristica:
essi nascono come pure immagini e puri suoni - ed è per questo che tanta
importanza hanno le frequenti e insistite iterazioni e allitterazioni, da
qualcuno considerate al contrario come scarsa preparazione retorica o come
facili ammiccamenti alla musicalità, e le impressioni visive e coloristiche di
cui parlavamo sopra - e trascinano con sé allusioni, più che significati;
impressioni, più che evidenze. Anche la frammentarietà del libro, su cui la
critica ha abbondantemente richiamato l'attenzione, è funzionale a questo
procedere tortuoso, sospinti dal vento della notte. Un vento che spira ancora e
sempre, non appena si aprono le pagine di un libro che resta tra i più vitali
del Novecento, tra i più fecondi di premesse e sviluppi (svolti da altri e in
altre direzioni).
Dino Campana sta sempre peggio. I suoi scoppi d'ira, i suoi litigi con la
polizia, i suoi vagabondaggi perennemente conclusi da un foglio di via che lo
rispedisce in Italia e a Marradi, luoghi da cui vorrebbe sopra ogni altra cosa
fuggire, lo hanno indebolito e hanno reso ancora più instabile il suo già
precario equilibrio psichico. È sempre più inerme di fronte all'"Italia
giolittiana, frasaismo borghese, imperialismo intellettuale, rospi, serponi e il
domatore, ascelle di maestrine in sudore, zitelle mature coll'ombra distesa sul
passo domenicale, Louis XIV (l'Italie c'est moi), sull'Arno secolare
rigovernatura delle lettere, industria del cadavere, onestà borghese, tecnica
cerebrale, manuale del pellirossa". Tutto ciò che gli altri accettano come norma
per lui è perversione atroce, molto di più di quelle delle gigantesche
prostitute mediterranee che incontra nei suoi incubi-pellegrinaggi notturni. È a
questo punto della sua vita, nel 1916, che incontra l'unico e disperato amore
della sua vita: Sibilla Aleramo, scrittrice femminista ante-litteram
copiosamente inserita nella famosa industria del cadavere. Lei ha quarant'anni e
un passato davvero avventuroso: divorziata dal marito, perso l'affidamento del
figlio, è già stata amante di Cardarelli, Boccioni, Boine e svariati altri
esponenti della cultura italiana del tempo; per finire, vanta amicizie illustri
come quella con il critico Emilio Cecchi (uno dei primi a dir bene di Campana).
Quel "viaggio chiamato amore" inizia per lettera, prosegue tra l'estate del 1916
e l'inizio del 1918 con qualche incontro e numerosi scambi di missive (che
verranno poi accorpate nel famoso epistolario); si conclude con scenate tremende
di Campana, un suo arresto, la scarcerazione avvenuta grazie alle amicizie della
donna.
Nel gennaio del 1918 il matto viene definitivamente chiuso tra i suoi simili,
nel manicomio di Castel Pulci, comune di Badia a Settimo. Lì Campana trascorre
quattordici anni; nel marzo del 1932 muore all'improvviso di una misteriosa
malattia. Che forse non era tanto misteriosa se si considera che tanti anni
prima, nel 1915, gli avevano diagnosticato la sifilide.
In tutto quel tempo Dino Campana ignora la letteratura in generale e la sua in
particolare, anche se a un certo punto i suoi Canti Orfici cominciano a
interessare grandi editori, come Vallecchi, che li pubblicano con numerose
varianti non autorizzate. A proposito delle quali l'unico commento dell'autore
è: "tutto va per il meglio nel peggiore dei mondi possibili: variante
vallecchiana". Subisce certamente la tortura dell'elettricità, usata senza
parsimonia per inibire comportamenti giudicati devianti; subisce anche le
ricorrenti visite, a partire dal 1926, dello psichiatra Pariani, che diventerà
il suo biografo, di fronte al quale ha come principale intento quello di non
dire nulla di sé, manifestando esclusivo interessamento per le notizie di
cronaca e gli eventi politici riportate dai giornali. Non sa, e con ogni
probabilità neppure gli interessa, che le giovani generazioni - le quali tutto
ignorano di lui tranne i suoi scritti - leggono e rileggono i Canti Orfici, e
presto li metteranno nell'albero genealogico della nascente poesia ermetica.
I Canti Orfici si concludono con alcune parole scritte in inglese: "They were
all torn and covered with the boy's blood" (Erano tutti avvolti e coperti col
sangue del fanciullo). Su quest'epilogo Campana aveva attirato l'attenzione di
Cecchi, scrivendogli che era l'unica cosa importante del libro. Nei deliri
precedenti il definitivo internamento spesso ricorreva l'idea di quel sacrificio
violento, di quell'ondata di sangue. La poesia era dunque, per Campana, una
religione; anzi, la religione per eccellenza. Solo nelle religioni compaiono
questi miti cruenti, dove il fanciullo (Bacco, ad esempio, ma anche Gesù) in cui
Dio si è manifestato viene scannato per purificare la terra e permettere che in
essa si riveli la divinità e si rinnovi la vita. Dino Campana si sentiva così:
anche lui ladro di fuoco, come Rimbaud, aveva pagato con il disprezzo, la
derisione e l'internamento il suo essersi avvicinato troppo a quell'inesprimibile
grumo di sangue, umori e visioni che costituisce l'intima essenza dell'uomo; e
il conto era stato tanto più salato quanto più la sua concezione dell'arte come
chiave per penetrare quel mistero andava contro una società che tendeva a
riportare l'arte nel mondo, rendendola solo una tra le molte possibilità di far
carriera.
Da questo titanico scontro Campana-uomo è uscito perdente. Ma la sua poesia,
quella no: perché in essa pulsa il sangue della verità.

|
